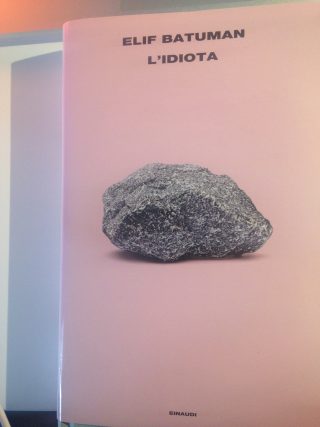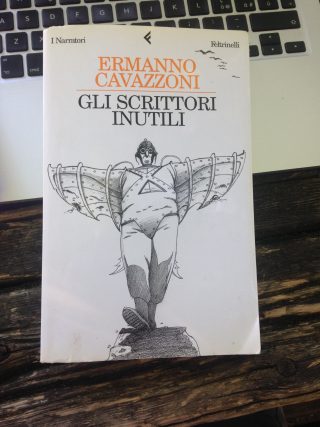Allora domani ho questa giornata piuttosto pesante, che mi devo svegliare prestissimo, ma voglio comunque vedere dove vuole andare a parare, Agata. Che sarà anche rossa, però io sento che sto reagendo in un certo modo inconfondibile. Spegni la luce, che mi vergogno, mi dice, e spogliati. Eseguo. Lei dice Non forzare niente, non forzare niente, mi prende in mano il cazzo e comincia a dire Com’è duro. Com’è grosso. Che cosa mi faresti con questo cazzone?
Io veramente queste cose di amore dialettico non le ho mai frequentate. Comunque ci provo: Ti prendo da dietro, le dico. Lei dice Sìì, e poi. E poi? Poi ti spacco in due come un melone, le dico. Sìììììì, dice lei, e poi? E poi, cosa le faccio? mi chiedo, che non so cosa dirle. Comincio a stantuffarti come un battello a vapore, le dico. Sìììì, dice lei, e poi? Cosa mi invento adesso? Meno male che si è bevuta il battello a vapore. Learco, e poi? insiste lei. Eh, poi ti infilo un dito nel culo. Sììììì, grida, sììììì, e poi? E che do bali. E poi ti faccio godere come una troia Sììììì. E poi ti rigiro e ti piscio in bocca tutta l’anguria che ho mangiato oggi Sììììììì, sìììììììì. Tutte le cose che mi piacciono, hai detto tutte le cose che mi piacciono, grida, ma lo grida con un tono che sembra che sia tristissima. Infatti lascia la presa e mi dice Mandami a casa, mandami a casa. Vai a casa, le dico, e mi scappa da ridere. No, adesso mi prendi da dietro, dice lei, e si gira e io comincio a tirarle giù le mutande, ma lei grida No, non forzare niente, non forzare niente. Cosa fareste, voi? Io, in questi momenti di indecisione, di solito mi accendo una sigaretta. E faccio così, vado in sala, prendo le sigarette dalla giacca e mi accendo una sigaretta. Learco! sento che mi chiama. Oh, le dico, e vado in camera. Accendi la luce, mi dice, che voglio che mi vedi tutta nuda. Accendo la luce. Lei è nuda. Si tocca. È stupido, vero? mi dice. Non è stupido, secondo te? Io non dico niente, che voglio vedere dove vuole andare a parare. Coricati di fianco a me, mi dice, e io mi corico e lei di nuovo mi prende il cazzo in mano e comincia a dire Com’è grosso. Com’è caldo. Me lo immagino tutto dentro di me. Cosa mi faresti, con questo dentro di me? Uguale. Ti prendo da dietro, ti spacco in due come un melone, comincio a stantuffarti come un battello a vapore, ti infilo un dito nel culo, ti faccio godere come una troia. Sììì, sìììì, sìììì. Tutte le cose che mi piacciono. Mandami via, mandami via.
La prima volta, va bene, la seconda, basta. Non siamo mica in un videogioco, che bisogna ripetere sempre le stesse cose. Questa è la vita reale, che si rischia inavvertitamente di tirarsi in casa dei matti furiosi, se non si sta attenti. Allora, dopo la sigaretta, vado in camera e le dico Cazzo, Agata, ma lo sai che ora è? No, dice lei. È l’una e mezza, è tardissimo. Io domani mi devo svegliare alle sette, le dico. E allora? chiede lei, appoggiata sul gomito destro, con una faccia tutta contrariata. Io, le dico, se non faccio due cicli di sonno, il giorno dopo sono una larva. E domani non posso assolutamente permettermi di non essere in forma, che devo fare una cosa importante in un castello. In un castello? dice lei. Eh, in un castello. Scusa, ma non ho tempo di spiegarti, che ogni minuto che passa sono minuti che rubo al mio secondo ciclo di sonno, il più importante. Senti, io dormire in due, non ce la faccio. Ti dispiace andare a casa? Dovresti però cambiarti in sala, che io mi infilo subito a letto, che non ho un minuto da perdere.
La beve, o fa finta di berla, che questa era ancora più grossa di quella del battello a vapore. Se ne va senza dire parola, con la faccia contrariata.
da Bassotuba non c’è
di Paolo Nori
[Feltrinelli, 2009]